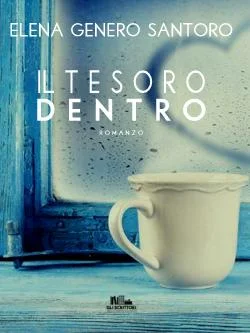Libri Recensione di Davide Dotto. Il pappagallo muto. Una storia di Sara di Maurizio De Giovanni (Rizzoli). Il giallo nell'era dell'IA e la rivincita dell'intuizione: non soltanto un gioco logico, ma luogo in cui la letteratura custodisce la dimensione umana dell’indagine.
Da qualche anno il romanzo giallo sta affrontando più di una sfida per restare al passo con i cambiamenti.Se esiste un “canone”, alcuni aspetti necessitano di un aggiornamento – non solo sul piano della scrittura. Più di un autore se ne è accorto.
Alcuni tratti non reggono il confronto con il presente: non basta più immaginare indagini condotte tra bistrot parigini, pipe fumanti e appostamenti alla Maigret. A meno di ambientare la vicenda in un’epoca passata (anni Ottanta, Novanta o primi Duemila), i nostri anni Venti – e i prossimi Trenta – pongono domande nuove.
Come si conduce un’indagine quando la tecnologia digitale sembra promettere soluzioni istantanee, scandagliando dati e connessioni in pochi secondi, quando tecnici informatici offrono risposte immediate senza muoversi dalla sedia – salvo rocambolesche irruzioni da serie TV come Criminal Minds – mentre ogni dettaglio della vita quotidiana viene archiviato con precisione maniacale?
Il racconto poliziesco deve reinventarsi, e fare del conflitto tra algoritmo e intuizione il suo nuovo motore narrativo.Ed è proprio su questo che riflette Il pappagallo muto, la settima indagine di Sara Morozzi.
Comparsa per la prima volta nella raccolta Sbirre, Sara porta con sé un passato segnato da scelte radicali: l’amore inseguito a costo di lasciare famiglia e certezze, il prezzo pagato senza concessioni al giudizio altrui. Ex agente dei Servizi, è una protagonista atipica: invisibile per scelta, dotata di un talento raro nell’ascolto e nell’interpretazione dei silenzi. Le sue indagini non puntano mai sulla spettacolarità, ma sulla capacità di leggere le persone. Anche in questa nuova avventura De Giovanni non cerca l’effetto del “chi è l’assassino?”, bensì la profondità del “perché”.
Il giallo non è soltanto un gioco logico, è il luogo in cui la letteratura custodisce la dimensione umana dell’indagine.
Qui si incontrano luce e ombra, memoria e oblio.Qui soprattutto il conflitto non si esaurisce nell’arresto del colpevole, ma diventa contatto con i demoni interiori, con le ferite e le fragilità che nessun software può archiviare. È questa tensione – irriducibilmente umana – a costituire l’identità profonda del genere.
Il detective classico, da Sherlock Holmes a Frate Guglielmo da Baskerville ne Il nome della rosa, è tormentato dalla vertigine dell'enumerazione infinita degli indizi. L'intelligenza artificiale, per sua natura, risolve questo problema. La macchina non si perde nella lista, ma la elabora interamente, fornendo la base oggettiva su cui l'intuizione umana può finalmente agire, senza perdere il controllo.
Non è una questione da poco se oggi si parla di trasparenza algoritmica, ovvero della necessità di comprendere i processi attraverso i quali una macchina giunge a una decisione.
Se l’intelligenza umana è fallibile, quella artificiale è spesso opaca.
E non ci si può accontentare di un generico «Lo ha stabilito l’algoritmo» o «Il software ha deciso». La differenza tra un detective e una scatola nera, del resto, è proprio questa: l’umano, anche quando intuisce la soluzione, sa ricostruirne i passaggi.In fondo, l'IA diventa un prezioso ausilio di quel "ragionamento all'indietro" che è la cifra di Holmes e la chiave per uscire dall'opacità dei dati. Holmes lo spiega con chiarezza in Uno studio in rosso (1887):
In solving a problem of this sort, the grand thing is to be able to reason backward… You see, I have already arrived at the conclusion without having all the facts. I then proceed to verify my solution. Arthur Conan Doyle, Uno studio in rosso, CAP 3
Un giallo che rinunciasse a tale percorso logico cadrebbe nel paradosso: un enigma con una soluzione inaccessibile. Ma se il giallo classico si fonda sulla dimostrazione logica, la realtà contemporanea spinge in direzione opposta.
Leggi anche | Recensione: Sara al tramonto, di Maurizio De Giovanni
E se Sherlock Holmes indagasse oggi?
Il fascino dell'investigatore inglese nasceva dal gap tra ciò che sfuggiva a tutti e ciò che lui, grazie a osservazione e ragionamento, riusciva a scovare. Quel vuoto di percezione era lo spazio in cui fioriva il giallo classico.Oggi, però, quel margine rischia di venire colmato – o peggio banalizzato – dalla tecnologia: non serve più il colpo d’occhio sul fango sugli stivali se esistono tracciamenti GPS, né riconoscere una certa cenere di tabacco se un database può segnalarlo in un istante.
Il giallo contemporaneo deve quindi reinventare quello spazio narrativo, mostrando che, anche nell’epoca degli algoritmi, resta un gap umano che nessuna macchina può azzerare: la memoria, la capacità di leggere ciò che non si lascia tradurre in dato.
La rivoluzione digitale non è solo una questione di strumenti; è una forza trasformativa che rimette in discussione il valore di certe abilità. Il classico investigatore che si affida all’intuizione, alle confidenze, all’osservazione sul campo, è a rischio di obsolescenza. Perché affaticarsi con lunghi interrogatori quando un’IA può tracciare movimenti, incrociare dati finanziari?
Emergono nuove professioni, esperti di cybersecurity, mentre le competenze "analogiche" passano in secondo piano.
In questa corsa al digitale, le abilità analogiche rischiano di sembrare superflue: riconoscere un’esitazione nello sguardo, condurre un interrogatorio con pazienza, conquistare la fiducia di un testimone.Eppure sono proprio questi i dettagli che nessun software sa riprodurre, e che spesso aprono varchi decisivi nelle indagini. Il giallo diventa così la cartina di tornasole di questi mutamenti, mettendo a confronto generazioni investigative e metodologie diverse.
Il pappagallo muto. Una storia di Sara di Maurizio De Giovanni ribadisce l’insostituibilità dell’elemento umano.
Le doti di Sara Morozzi e del suo gruppo (Andrea, Teresa), considerate marginali o anacronistiche, trovano invece spazio nelle zone d’ombra che la tecnologia non sa illuminare.Si rivela decisiva la capacità di collegare fatti, e di trasformare anomalie ed errori in indizi.
Il romanzo non si concentra sul “chi” o sul “come” del crimine, ma soprattutto sul “perché”.
I personaggi, e in particolare Sara, mostrano come il delitto affondi le radici nella complessità delle relazioni umane, nei segreti, nelle passioni e nelle fragilità.
Sara Morozzi e Andrea Catapano, messi a riposo, diventano così figure considerate anacronistiche in un mondo di tecnici informatici e analisti forensi digitali. Eppure, proprio la loro marginalità diventa forza narrativa. Non sono reliquie, ma personaggi centrali di un nuovo paradigma narrativo: resistono non per nostalgia, ma perché incarnano ciò che nessuna tecnologia può sostituire.
Il giallo diventa allora un atto di memoria.
Indagando nei segreti e nelle motivazioni di situazioni e personaggi, si riportano alla luce frammenti di verità in cui il male e le debolezze umane ripropongono schemi che nessuna IA può cogliere fino in fondo. La saggezza, contaminata dall’esperienza, continua a battere il dato puro.Scrivere un giallo oggi significa misurarsi con tensioni che esigono di restituire spessore umano a un genere che vive di dettagli, esitazioni, illuminazioni. È una sfida duplice: narrativa ed etica, perché il giallo interroga il rapporto tra verità e giustizia, tra prova e interpretazione.
Maurizio De Giovanni sceglie di rimettere al centro l’esperienza, la memoria e il dubbio. Sara Morozzi non è l’antitesi della tecnologia, ma la dimostrazione che nessuna macchina può sostituire la capacità di leggere l’animo umano. È in questa frattura che il giallo contemporaneo trova nuova linfa: nel ricordarci che la verità non si riduce a un calcolo, ma nasce da uno sguardo che coglie ciò che sfugge alle griglie degli algoritmi.
Vale la pena aggiungere due ulteriori aspetti.
L’Intelligenza Artificiale procede per sequenze lineari, mentre l’intelligenza umana vive di simultaneità: può cucinare e nello stesso tempo rispondere a una telefonata, ascoltare una canzone e collegare tra loro dettagli marginali. È questa capacità di intrecciare piani e tempi che distingue Sara e Andrea, restituendo al lettore l’impressione che l’indagine sia, prima di tutto, un atto umano.Ciò che chiamiamo “intelligenza artificiale” è, in fondo, un’intelligenza alternativa: potente nei dati, nei calcoli e negli incroci logici, ma priva della simultaneità incarnata della coscienza. Lo ricorda Jeanette Winterson in 12 Bytes. Come siamo arrivati fin qui, dove potremmo finire in futuro, invitandoci a “rallentare” per capire cosa significa davvero essere umani. La via scelta da Sara Morozzi – intrecciare intuizione, memoria e presenza corporea – non è solo moralmente difendibile: è forse l’unico modo per non lasciarci definire da algoritmi troppo veloci e troppo silenziosi.
Non a caso, l’interesse intorno a Sara Morozzi si sta ampliando anche oltre i libri.
Dai primi due romanzi della serie è tratta una serie TV, con protagonista Teresa Saponangelo, che porta sullo schermo la “donna invisibile” creata da Maurizio De Giovanni. Non si tratta soltanto di un adattamento, ma della conferma che la sua vicenda parla al nostro tempo, intercettando paure e desideri che vanno oltre la cronaca nera. La serie televisiva coglie con precisione questa dimensione liminale di Sara: un personaggio-soglia che scosta la cortina, muovendosi con agilità tra luce e ombra. Non più soltanto una donna invisibile, ma una guardiana silente, un’Atena dagli occhi cerulei, immagine che avevo già evocato in un’altra recensione dedicata alla serie di Sara Morozzi.
Il pappagallo muto
Una storia di Sara
di Maurizio De Giovanni
Rizzoli
Gialli/crime/noir
ISBN: 978-8817182072
Cartaceo 18,05€
Ebook 10,99€
Ascolta l'audiolibro
Quarta
Al parco, seduti su una panchina vicino ai bambini che giocano, potrebbero sembrare due innocui vecchietti, Sara Morozzi e Andrea Catapano. Nessuno indovinerebbe che sono stati per anni i migliori agenti sulla piazza. A sorpresa, ora, i Servizi hanno di nuovo bisogno della donna invisibile e del cieco dalle straordinarie doti investigative. Si tratta di un'operazione in cui non possono usare mezzi tecnologici, solo l'intercettazione personale alla vecchia maniera, che i due maneggiano come nessun altro. Decidono di accettare: se hai fatto quel lavoro, ti resta nel sangue, non riesci a tirarti indietro nemmeno dopo anni.
Ma Sara e Andrea capiscono presto di aver sbagliato a rimettersi in attività. L'incarico potrebbe portarli a rischiare grosso, stretti in un ingranaggio troppo più grande di loro. Per fortuna non è sola, Mora: Teresa è sul piede di guerra, e ci sono i fidatissimi Pardo e Viola, oltre al Bovaro del Bernese Boris, a vegliare sul suo destino incerto e su quello di Andrea, in un'indagine che rivelerà, una svolta dopo l'altra, un intricato groviglio di interessi segreti.
|
Davide Dotto |