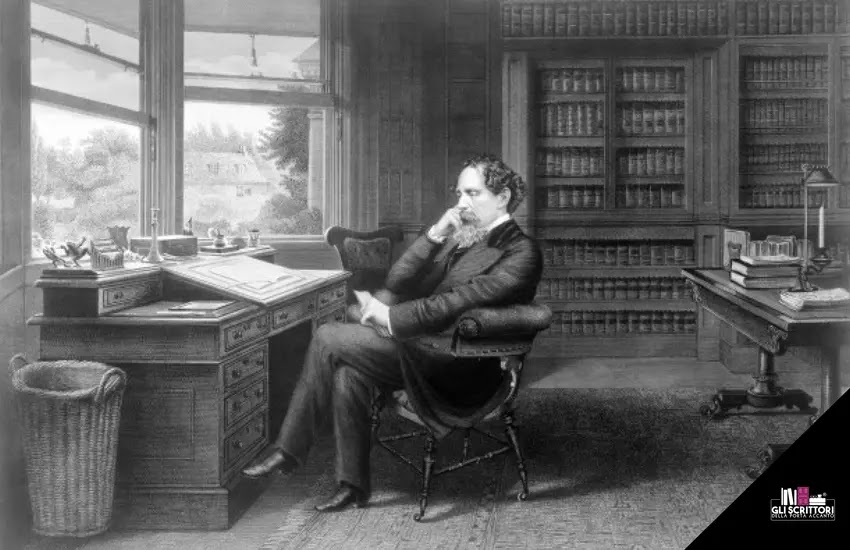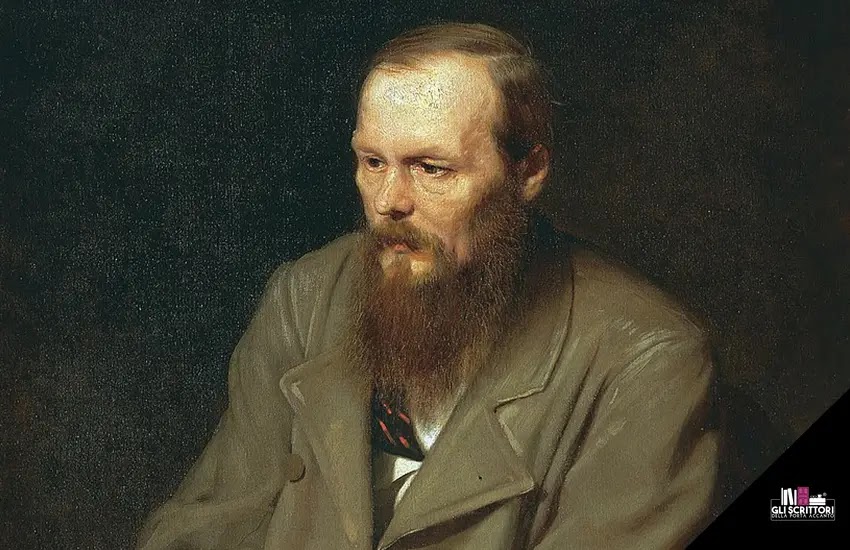Musica Di Davide Dotto. Di cover in cover, un viaggio tra le versioni di Rain Rain Rain: da Simon Butterfly a Marie Laforêt, tra traduzioni, riscritture affettive e poetiche, una trasformazione che non è solo linguistica, è soprattutto narrativa, poetica, culturale. E riflette la vitalità stessa dell’atto interpretativo, quando abbandona l’imitazione per farsi scrittura originale.
Nel vasto e variegato mondo musicale, prima o poi ci siamo imbattuti nel termine cover, un fenomeno più complesso di quanto possa sembrare. Una cover può essere molte cose: un gesto di appropriazione, una rilettura che getta nuova luce, una riscrittura radicale capace di infondere nuova anima a un brano.Tradotta e reinterpretata, una canzone può davvero trasformarsi in qualcos’altro, in una nuova storia.
Il dibattito sul significato e sul valore delle cover non appartiene solo al passato: continua ad animare la scena musicale contemporanea. Ne è prova la recente querelle tra Laura Pausini e Gianluca Grignani a proposito del brano La mia storia tra le dita, che ha riportato al centro la questione della paternità di un testo, della melodia e del diritto all’interpretazione.Alcune canzoni che oggi consideriamo iconiche sono, in realtà, cover.
Non mancano adattamenti totali che spostano il punto di vista, cambiano il genere, riscrivono l’emozione. In questi casi, una voce maschile diventa femminile (o viceversa), un lamento amoroso si trasfigura in invocazione familiare, una metafora meteorologica si dissolve in una narrazione drammatica: il testo si emancipa proponendo una nuova storia, nuovi protagonisti e un differente destinatario emotivo.
Rain, rain
Oh, rain, rain
Oh, rain, rain va, la
Oh, rain, rain va, la
Oh, rain, rain
Since you went away
Oh, rain, rain
Beating down all day
Oh, rain, rain
Never seen such rain
Oh, rain, rain
Everything in rain
Lovers often fight about fat smallic quarrel
Making up will be born right that′s the moral
When we parted that mind you, you're mine
Did our hearts mean goodbye
So lovers separate and hurt one another
Leaving all to fate and then they discover
They believe it makes two lovers same
So they must start again
Oh, rain, rain
Since my love has gone
Oh, rain, rain
Sun has never shone
Oh, rain, rain
Hear it beating down
Oh, rain, rain
Feel like I′m gonna drown
Oh, rain, rain
Wonder where you are
Oh, rain, rain
Never see the star
Oh, rain, rain
Can it start the strain
Oh, rain, rain
Life is only rain
Say we meet again I can't live without you
Every dream I ever dream is about you
I shall know when I see your eyes shine
You will always be mine
Oh, rain, rain
Since you went away
Oh, rain, rain
Beating down all day
Oh, rain, rain
Flooding through my brain
Oh, brain, brain
Driving me insane
Insane, insane.
Ne è un esempio emblematico Viens Viens di Marie Laforêt, riscrittura profonda di Rain Rain Rain di Simon Butterfly, entrambe pubblicate nel 1973.
Il brano originale, Rain Rain Rain di Simon Butterfly, non parla che della pioggia, usata come metafora – ossessiva e prevedibile – di una delusione amorosa. Nella rielaborazione francese, il testo firmato da Ralph Bernet mette in scena la supplica straziante di una figlia rivolta al padre assente.Il punto di vista narrativo si ribalta: non è più quello di un innamorato deluso. Il tono si fa più lirico e disperato, l’evocazione della pioggia scompare, lasciando spazio a un dialogo interiore intimo e doloroso. Questo effetto è reso ancor più intenso dalla capacità recitativa di Marie Laforêt, artista poliedrica che riesce a dare voce a emozioni complesse e sfumate.
Con una filmografia che conta circa 50 titoli, Laforêt era innanzitutto un'attrice affermata, e questo si percepisce chiaramente nella sua interpretazione – in Italia la ricordiamo, tra l’altro, nella serie La Piovra 3 (1987) e nell’adattamento di A che punto è la notte di Nanni Loy, tratto dall’omonimo romanzo di Fruttero e Lucentini (miniserie del 1994). L'interpretazione data è talmente intensa e autentica da suggerire che il vissuto personale di Marie Laforêt si sia fuso con le parole del brano, conferendo alla supplica una profondità e un'emotività uniche.
Esiste anche una versione italiana (adattata da Gian Pieretti), Lei Lei, incisa dalla stessa Marie Laforêt e successivamente ripresa da Dalida.
Lei Lei di Dalida rispecchia in larga parte la struttura e il contenuto di Viens, Viens, ma introduce variazioni che ne modificano la percezione.Una differenza rilevante emerge nel verso «torna a casa se puoi»: una formula che introduce un margine di dubbio, una possibilità sospesa – forse una forma di pudore emotivo.
L’intensità non si attenua, ma si traduce in una malinconia più trattenuta, scandita da un lirismo delicato e convenzionale.
Viens, viens
Viens, viens, c'est une prière
Viens, viens, pas pour moi mon père
Viens, viens, reviens pour ma mère
Viens, viens, elle meurt de toi.
Viens, viens, que tout recommence
Viens, viens, sans toi l'existence
Viens, viens, n'est qu'un long silence
Viens, viens, qui n'en finit pas.
Je sais bien qu'elle est jolie cette fille
Que pour elle tu en oublies ta famille
Je ne suis pas venue te juger
Mais pour te ramener...
Il parait que son amour tient ton âme
Crois-tu que ça vaut l'amour de ta femme
Qui a su partager ton destin
Sans te lâcher la main?
Viens, viens, maman en septembre
Viens, viens, a repeint la chambre
Viens, viens, comme avant ensemble
Viens, viens, vous y dormirez.
Viens, viens, c'est une prière
Viens, viens, pas pour moi mon père
Viens, viens, reviens pour ma mère
Viens, viens, elle meurt de toi
Sais-tu que Jean est rentré à l'école
Il sait déjà l'alphabet, il est drôle
Quand il fait semblant de fumer
C'est vraiment ton portrait.
Viens, viens, c'est une prière
Viens, viens, tu souris mon père
Viens, viens, tu verras ma mère
Viens, viens, est plus belle qu'avant.
Viens, viens, ne dis rien mon père
Viens, viens, embrasse moi mon père
Viens, viens, tu es beau mon père
Viens, viens.Lei, lei canta una preghieraLei, lei
Lei, lei che ritorni spera
Lei, lei si sta consumando
Lei, lei torna o morirà
Lei, lei ogni primavera
Lei, lei è bella come era
Lei, lei sola si dispera
Lei, lei aspetta solo te
Io io so che l'altra è molto graziosa
E per lei tu scordi la tua famiglia
Io non voglio giudicarti pero
Torna a casa se puoi
E sembra quasi che il suo amore ti leghi
E la mano di chi t'ama rinneghi
Ll destino di chi è stato con te
Tu scordare non puoi
Lei, lei un giorno di settembre
Lei, lei tinse la tua stanza
Lei,lei non puo stare senza
Lei, lei torna o morira
Lei, lei canta una preghiera
Lei, lei che ritorni spera
Lei, lei si sta consumando
Lei, lei torna o morirà
Il più piccolo è tornato già a scuola
Ci diverte quando legge qualcosa
Se fa finta di fumare pero
Ci ricorda un po te
Lei, lei torna padre mio
Lei, lei sto aspettando anch'io
Lei, lei nella nostra casa
Lei, lei manchi solo, solo, solo, solo, solo tu
Lei, lei non mi dire niente
Lei, lei oggi è più contenta
Lei, lei oggi è insieme a te
Lei, lei oggi è insieme a te
Lei, lei torna padre mio
Lei, lei sto aspettando anch'io
Lei, lei nella nostra casa
Lei, lei manchi solo tu.
Le versioni a confronto: Viens Viens e Lei Lei
È possibile che anche alcune scelte linguistiche abbiano contribuito alla minore incisività del brano: espressioni come “tinse la tua stanza” o “E la mano di chi t'ama rinneghi” risultano leggermente auliche, e poco adatte alla naturalezza emotiva che ci si aspetta da un pezzo pop.Questo registro, più vicino alla lingua letteraria che parlata, potrebbe aver reso Lei Lei meno immediata, limitandone la presa sul pubblico italiano.
Il ritornello di Lei Lei introduce un effetto straniante: invece di rafforzare il coinvolgimento emotivo, come accade con il francese, tende a frammentare la narrazione, creando distanza con l’ascoltatore. In Viens Viens, «Maman en septembre... a repeint la chambre», la presenza esplicita della madre rafforza il legame affettivo, rendendo la scena più vivida. L'interpretazione italiana, invece evoca una figura terza, un’impersonalità che attenua l’impatto drammatico.
Questa scelta, unita al lessico ricercato (“tinse”, “rinneghi”), contribuisce a un’eleganza formale che però ne raffredda l’emozione. Tuttavia, è proprio grazie all'interpretazione altrettanto intensa di Dalida che questa rilettura lascia un segno, colmando le incertezze linguistiche con una vocalità drammatica e avvolgente. Dove le parole non arrivano, arriva la voce.
Ciò emerge con ancora più forza nell’ultima strofa, dove si intuisce un cambiamento di atmosfera: il ritorno sembra imminente, forse è già avvenuto.
È un finale aperto, ma segnato da una fiducia trattenuta – una possibilità di riconciliazione che Viens Viens non contempla.È una scelta che può essere letta anche alla luce del contesto storico italiano degli anni Settanta, segnato dall’approvazione della legge sul divorzio (1970) e dal successivo referendum abrogativo (1974). In quegli anni, l’idea di famiglia veniva profondamente ridefinita, tra nuove forme di rottura e il bisogno di elaborare in modo diverso il dolore affettivo.
L'adattamento riflette proprio questo clima: da un lato, il riconoscimento della sofferenza di una donna abbandonata; dall’altro, la speranza che la frattura possa essere ricomposta. Un messaggio che, nella sua apparente semplicità, traduce poeticamente la tensione tra un mondo che cambia e una visione ancora saldamente radicata nella tradizione.
L'originale inglese di Simon Butterfly presenta un approccio puramente sentimentale.
Rain Rain Rain procede per ripetizioni insistenti che creano un effetto ipnotico, costruendo l'intera composizione attorno a una metafora meteorologica essenziale e di per sé scontata. La pioggia diventa il correlativo oggettivo di una condizione emotiva, sviluppata su un nucleo tematico circolare.La versione Viens Viens aggiunge invece l'aspetto narrativo, un abbozzo di caratterizzazione e lo sviluppo di un vero e proprio racconto con dignità letteraria.
Ma c'è di più.
Il testo di Rain Rain Rain è costruito su una serie di stereotipi che mal si prestano a una riproduzione diretta in altre lingue senza perdere mordente.
Per poter funzionare in altri contesti, la canzone ha dovuto essere rimodellata e adattata con decisione.È diventata, insomma, una matrice da cui si sono generate versioni autonome e profondamente differenti. La trasformazione non è quindi solo linguistica: è narrativa, poetica, culturale. E riflette la vitalità stessa dell’atto interpretativo, quando abbandona l’imitazione per farsi scrittura originale.
Traduzioni parallele o progetto condiviso?
C’è un dato che colpisce per la sua forza simbolica e logistica: Rain Rain Rain, Viens Viens, Lei Lei, e persino la versione spagnola Ven ven di Marisol, sono tutte pubblicate nel 1973. Non si tratta di semplici adattamenti successivi, ma di varianti coeve, nate quasi in parallelo in diversi Paesi europei. A distanza di mesi (e talvolta settimane) l’una dall’altra, rivelano l’esistenza di una vera e propria operazione editoriale continentale, pensata per plasmare un brano-matrice.Il successo non precede le versioni: le crea. Assistiamo alla diffusione sincronica di una melodia essenziale – di fatto un brogliaccio – che si lascia riscrivere.
Al tempo stesso, questa pluralità di voci imprime una dimensione corale, rendendo ciascuna versione parte di una costellazione narrativa che attraversa confini, generi e sensibilità.
Nel mondo della canzone d’autore, non era raro che un brano venisse lanciato su più mercati attraverso versioni parallele in diverse lingue, a volte con il coinvolgimento diretto di artisti di nazionalità diverse.
Questa strategia di co-creazione e adattamento internazionale era già prassi consolidata negli anni Sessanta e Settanta, soprattutto per brani destinati al grande pubblico europeo. Canzoni come Comme d’habitude (ripresa poi da Frank Sinatra nella versione My Way) o Tornerò dei Santo California (riproposta poi come Apprends-moi da Mireille Mathieu) sono esempi noti. Tuttavia, in quei casi la dinamica sembra più lineare: esisteva un originale riconoscibile, da cui derivavano versioni successive.Nel caso di Rain Rain Rain ci troviamo di fronte a un fenomeno atipico per intensità, simultaneità e diffusione.
Non è solo il segno di una buona intuizione commerciale, ma l’espressione di una collaborazione creativa transnazionale, capace di rendere un’idea musicale in apparenza modesta in un successo europeo multiforme. Un caso che anticipa, sotto molti aspetti, le logiche globali della musica pop contemporanea.È possibile che il fenomeno abbia seguito una dinamica a effetto domino: il successo di Viens Viens nella versione di Marie Laforêt avrebbe dimostrato il potenziale commerciale del materiale melodico, innescando una reazione a catena che ha portato alla diffusione quasi simultanea delle altre.
La matrice musicale di Simon Butterfly – inizialmente poco considerata dai produttori – avrebbe trovato legittimazione proprio nel trionfo francese.
Zitas: la risposta greca.
Ogni nuova interpretazione – dalla spagnola Ven ven di Marisol alla greca Zitas di Marianna Toli – nasce dal desiderio di replicare un successo adattandolo ai propri mercati linguistici. Il risultato è un fenomeno spontaneo di amplificazione culturale: una canzone che diventa europea non per pianificazione, ma per contagio artistico.Alla mappa si aggiunge, grazie alla versione greca, un ulteriore tassello prezioso: essa prende una direzione autonoma rispetto sia alla matrice inglese sia alla riscrittura francese. Il titolo stesso, che significa “Chiedi”, inaugura una poetica del desiderio e della ricerca, sostituendo la ripetizione ossessiva di Rain Rain Rain con una litania matura, fatta di appelli e invocazioni per ricucire un legame spezzato.
Non c’è traccia del dramma familiare della versione di Marie Laforêt, né della malinconia liquida dell’originale inglese.
Il testo greco si presenta come una risposta consapevole e stilisticamente elaborata al lamento dell’amante abbandonato. Dove Simon Butterfly piange nella pioggia e si sente sopraffatto dalla perdita, Marianna Toli restituisce una maggior complessità. È il punto di arrivo di un processo di metamorfosi testuale che passa dal vittimismo all’introspezione attiva, dalla nostalgia alla possibilità di rinascita.Volendo, potremmo ora leggere il trittico europeo come una vera e propria sequenza di narrazioni complementari, generate da una stessa base melodica ma autonome nei contenuti.
Leggi anche Davide Dotto | Recensione: Le Désespoir des singes... et autre bagatelles, di Françoise Hardy
Metamorfosi a confronto: tre voci, tre prospettive.
Questo conferma che non ci troviamo di fronte a semplici adattamenti, ma a un processo di rielaborazione profonda del testo che ha seguito percorsi paralleli.La traduzione del testo greco rivela la dimensione più affascinante dell'operazione: l'interpretazione di Marianna Toli non si limita a nobilitare il materiale grezzo, ma risponde al lamento inglese. Se Simon Butterfly geme «rain, rain, since you went away», la cantante greca replica con «ζητάς» (chiedi), convertendo la passività in azione, il vittimismo in proposta. Non è più piango perché te ne sei andato, ma chiedere, aprire alla possibilità di un ritorno (riallacciandosi al testo francese). È alchimia narrativa: ribalta i ruoli. Mentre Marie Laforêt modifica il genere (da amoroso a familiare), Marianna Toli ribalta la prospettiva (da passiva ad attiva).
La versione greca Zitas – ripresa nella cover di Evridiki del 1991 – non si limita a riscrivere il brano originale, ma lo contraddice silenziosamente, rispondendo a un certo immaginario sentimentale tipico della canzone d’autore maschile anni Sessanta e Settanta. Un universo in cui l’uomo, abbandonato, si dispera e sublima la donna assente, elevandola a figura angelicata e silenziosa, mentre evita ogni dialogo.
La donna diventa un’assenza decorata di fiori, mentre l’emotività maschile occupa tutta la scena.
È l’immaginario di brani come Fiori bianchi per te interpretata da Salvatore Adamo – già esso stesso riscrittura di un originale francese – o Rose rosse di Massimo Ranieri.Anche Rain Rain Rain si muove in questo solco, una forma di autoassoluzione passivo-aggressiva. La donna è evocata come colpevole e inaccessibile, e la pioggia dell’abbandono diventa un alibi per non agire.
Contro questa narrazione, Zitas propone un controcanto: una donna che si interroga, che cerca, che chiede, ma che non si annulla. È una voce che tenta di ricostruire un legame su basi nuove, senza indulgere nel lamento o nella mitizzazione. In questo senso, la versione greca è una risposta culturale e poetica a un lessico sentimentale datato.
I testi esaminati diventano specchio di epoche e di modelli relazionali che la lingua veicola e cristallizza, senza che nessuno possa dirsi dominante sugli altri.
Non è solo questione di stile, ma di posizionamento dell'io: chi parla, a chi, e perché? Il linguaggio da cui queste riscritture sembrano affrancarsi è quello del controllo, della colpa, del non-ascolto — un immaginario che non scompare, ma si evolve attraverso i decenni.Dalla vittimizzazione sentimentale degli anni Sessanta e Settanta ("piango perché mi hai lasciato") si passa, talvolta, alla sacralizzazione dell’io creativo: un artista che reclama spazi inviolabili anche dagli affetti più prossimi, e che talvolta — l'ha messo in luce in un suo testo Roberto Vecchioni — riduce figli e compagna a vuoti dettagli sacrificati al trenino della letteratura.
È un’altra forma di autoreferenzialità, più colta ma non meno problematica: il soggetto-poeta si erge a custode del senso, e in questo stesso gesto rischia di dissolvere l’altro — non più assente per dolore, ma marginale per struttura. L’evoluzione è emblematica: dai fiori per l’assente ai monologhi del genio incompreso, il denominatore comune resta l’io al centro, che pretende comprensione senza offrirla, ascolto senza restituirlo.
Forse è proprio questo il destino delle canzoni: non restare mai ferme.
Passano da una lingua all’altra, cambiano voce, prospettiva, funzione. Si piegano ai codici del tempo e, nel farlo, ne rivelano le crepe. Ogni nuova rielaborazione è una domanda rivolta al presente: che cosa possiamo ancora dire dell’amore, della perdita, del ritorno?E così, dalla pioggia sentimentale di Simon Butterfly al pudore filiale di Marie Laforêt, fino alla fermezza poetica di Marianna Toli, non assistiamo soltanto a un gioco musicale. Assistiamo alla riscrittura del linguaggio affettivo.
Non si può dire, al momento, molto di più: le fonti disponibili sulla genesi e la diffusione di Rain Rain Rain sono piuttosto lacunose. La stessa voce di Wikipedia si limita a riportare dati essenziali su autore, anno e adattamenti principali, senza approfondire le dinamiche editoriali o gli aspetti narrativi e poetici delle letture che ne sono derivate.
Cercando online, ci si può imbattere in molte altre versioni, persino in una in lingua tedesca dello stesso Simon Butterfly, coeva a quella inglese.
In fondo, si potrebbe dire che il brano originale sia la cover di se stessa, un paradosso che ne rivela la natura più autentica: non un testo, ma un’idea musicale in costante metamorfosi.
Tra gli altri testi in circolazione, si segnala quello cecoslovacco di Karol Duchon, Šiel šiel (si potrebbe tradurre con "se ne andò" o "partì"), che assume un'accezione quasi eroica, trasformando il lamento in un viaggio epico, solenne.Poi c'è quello polacco di Lidia Stanisławska, Wiem wiem (un verbo che richiama Viens viens come la spagnola Ven ven, ma che si deve tradurre con "So so") che si focalizza su una nuova introspezione.
Merita un cenno la turca di Füsun Önal, Gel gel, che ha un tono più leggero e quasi giocoso.
Infine, la rielaborazione orchestrale di Paul Mauriat che, pur facendo a meno di un testo, veicola un'emozione profonda sottolineando, in fondo, la versatilità e la forza intrinseca della melodia originaria.
|
Davide Dotto |