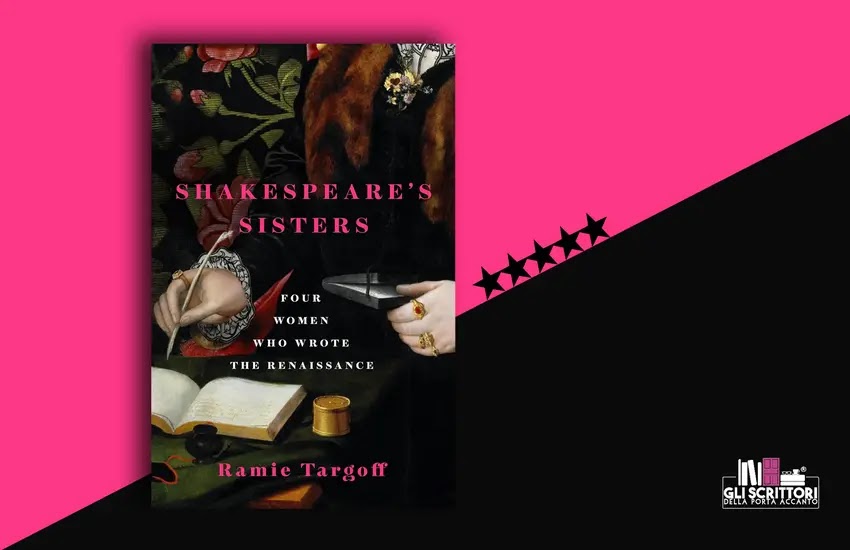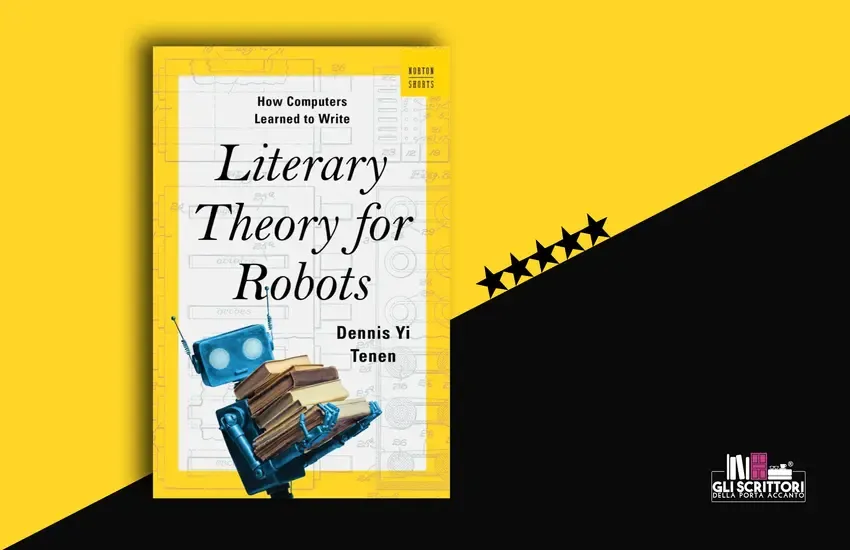Libri Recensione di Davide Dotto. Chiudo la porta e urlo di Paolo Nori (Mondadori). Dalla parola scritta alla parola recitata: il monologo come strumento di narrazione. Attraverso la biografia e la critica letteraria, l'autore intreccia la propria esperienza personale con le vite e le opere degli autori di cui scrive, offrendo una prospettiva particolare.
I libri di Paolo Nori sono monologhi per il teatro, vanno letti così, recitati. È la stessa punteggiatura a dirlo, costruita per segnare le pause del parlato più che l’organizzazione sintattica e del periodo. Un esempio evidente di questo stile è il libro "Sanguina ancora", dedicato a Delitto e Castigo di Dostoeskij e pubblicato nel 2021. Chiunque abbia letto questo libro avrà notato come la punteggiatura guidi il ritmo della lettura. Leggi anche Davide Dotto | Recensione: Sanguina ancora, di Paolo Nori
Tra oralità e scrittura prevale il racconto di un aedo o di un trovatore.
Il ritmo è cadenzato, simile a una recita che aiuta la memoria e richiama immagini, grazie all'uso di figure retoriche. Potrebbe avere un significato rituale, alla fine, il ricorso all’anafora, all’epifora. E a quel particolare effetto di accumulare, di trattenere cose, pensieri, dissonanze e consonanze prima che sfuggano.Il suo modo di scrivere, così diverso dalle consuetudini letterarie, rappresenta già una piccola rivoluzione.
Un modo per sottrarsi alle regole linguistiche più rigide, dando l’illusione di un’improvvisazione spontanea. Poi arriva il tema, di colpo, “senza preavviso”, e il tutto funziona molto bene sulla pagina scritta che, a riguardo, è un ottimo registratore.Per comprendere appieno questo stile, è utile leggere più opere di Nori, poiché esse sono interconnesse attraverso richiami reciproci e rimandi tematici. Esprime l’arte sui generis di conquistare una dimensione – non solo narrativa – totalmente altra, fatta di rimandi, coincidenze preavvertite.
La scrittura stessa è un dialogo multiforme tra dimensioni.
Fa a meno di un canone consolidato, viste forse come velleità di cui fare a meno, e che richiedono un apposito talento. Non è facile quello che riesce a Paolo Nori: trasportare da una sfera all’altra qualcosa che è connaturato in un altrove, per esempio “far diventare la mia passione, la letteratura, il mio mestiere». E qui emergono tracce di profondi legami, a partire da Dostoevskij e dalla sua disperazione, a sondare i segreti di un’anima che non è poi così lontana dalla propria. Simili affinità le ha trovate entrando e uscendo dalla vita di Anna Achmatova. Leggi anche Davide Dotto | Recensione: Vi avverto che vivo per l'ultima volta, di Paolo Nori
Il racconto autobiografico di Paolo Nori si inserisce in quello dei suoi autori come un insieme di note a margine.
Note che contribuiscono a creare un discorso più ampio e a rivelare una certa unità. Un procedimento simile, seppur con un diverso respiro stilistico, lo ritroviamo in Emanuele Trevi, che nei suoi libri stabilisce un ponte tra il proprio vissuto e quello di figure letterarie: in Qualcosa di scritto con Pier Paolo Pasolini e Laura Betti, in Due vite con Pia Pera e Rocco Carbone, o in La casa del mago con il padre Mario Trevi, noto psicanalista.La letteratura qui diventa un campo di risonanze e rimandi, dove il confine tra autobiografia e critica si dissolve, e l’atto dello scrivere si trasforma in un’esperienza di immersione nella vita degli altri.
Attraverso la biografia e la critica letteraria, Paolo Nori intreccia la propria esperienza personale con le vite e le opere degli autori di cui scrive, offrendo una prospettiva particolare.
Ma in questa immersione si va oltre la letteratura: non si parla più soltanto di parole e pagine scritte, ma di anime, di direzioni da prendere, di come stare al mondo.Ci sono famiglie, luoghi, storie, connessioni con il presente e con il passato, ed è un continuo interrogarsi su come si possa abitare l’esistenza. Non c’è la pretesa di trovare un senso, né di rivelare una verità ultima, ma solo il bisogno di cercare, di ascoltare, di entrare dentro le cose. L’incontro di questo libro è con il poeta Raffaello Baldini. Il suo ritratto è costruito a pennellate decise e impressionistiche.
L’immagine che ne ricaviamo è quasi una fotografia.
È un poeta che scrive nel “bel dialetto di Sant’Arcangelo di Romagna” e “traduce a piè pagina in bell’italiano i suoi versi” e introduce inoltre la questione della lingua, molto più comune di quanto si creda. Ci sono senz’altro confini comunali, provinciali, regionali, insieme ad arrivi, partenze, ritorni. Ci sono le Langhe di Pavese che assurgono a più di un suggerimento, e che potrebbero essere la Catania di Giovanni Verga come la Malo di Luigi Meneghelli, le borgate romane di Pasolini. E per Paolo Nori c'è Parma.L'elenco diventa lunghissimo e inesauribile. È una sorta di freno, un invito a fermarsi per raccogliere qualcosa di sé, una radice, una provenienza che si apre all'universo. Ecco che Parma incontra la Russia, Catania unisce il proprio destino a Firenze e Milano (Verga), le Langhe si collegano agli Stati Uniti (Pavese, la letteratura americana, le sue traduzioni).
Ho cominciato a leggere i miei racconti ad alta voce, e è successo che naturalmente, io, sapendo che poi li avrei dovuti leggere ad alta voce, avevo cominciato a scriverli un po’ come se fossero parlati, in un certo senso, e all’improvviso quel triangolo di cui parlavo prima, io, computer, e cielo della letteratura, cioè io, computer e crusca e cruscanti, era diventato un triangolo con un vertice infinito , cioè era diventato un triangolo io computer mondo, e improvvisamente le cose da scrivere mi venivano su da tutte le parti… Paolo Nori, Chiudo la porta e urlo
Il contrasto che si evidenzia fa sì che mentre Raffaello Baldini scrive in dialetto romagnolo e fornisce traduzioni in italiano, Paolo Nori adotta un approccio del tutto diverso ma coerente: crea una sua voce distintiva infrangendo le strutture letterarie convenzionali.
Questo rimanda a una questione più ampia nella letteratura italiana su come gli scrittori possano catturare un'espressione autentica. C'è scoperta ma non imitazione, c'è condivisione ma nessuna angoscia dell'influenza. Giovanni Verga fa in fondo la medesima cosa a sua volta, pur in una modalità speculare e contraria: invece di parlare direttamente in siciliano, cercava di creare un italiano standardizzato.Il suo obiettivo era trasmettere l'essenza della vita e dei modelli di pensiero siciliani. E a sua volta Manzoni con il suo sciacquare i panni in Arno perseguiva un obiettivo simile. E di sicuro "il buon italiano" di Baldini doveva molto a questo insieme di esperimenti e predecessori.
Alla fine, Chiudo la porta e urlo si fa scuola di scrittura oltre che di lettura, perché – nella questione della lingua – ci vuole qualcosa che vada oltre la lingua stessa.
È un tipo di scrittura che non si limita a raccontare, ma crea connessioni, stabilisce legami tra storie e vissuto personale. Un'operazione che, con una diversa sensibilità – come si è visto – troviamo anche nei libri di Emanuele Trevi, che costruisce il proprio discorso letterario intrecciando la sua biografia con le vite di scrittori e artisti: da Pasolini a Pia Pera, fino alla figura del padre Mario Trevi in La casa del mago. In entrambi i casi, il libro non è solo narrazione, ma diventa un luogo di incontro, un atto di ascolto.E questo è detto nero su bianco: «Ci son dei libri che son scritti così bene, in italiano italiano, damaschi ebani fiori tappeti e bronzi, che è come se non si vedesse niente».
Quando succede "il contrario" è un evento. Ecco la lezione: è una dimensione che non cerca definizioni o verità assolute, ma connessioni tra storie, tra vite, tra direzioni possibili. Scrivere, per Nori e per chi si riconosce in questa tensione, non è solo narrare, ma provare a orientarsi nel caos dell’esistenza, con il linguaggio come bussola e non come punto di arrivo.
Chiudo la porta e urlo
di Paolo NoriMondadori
Narrativa biografica | Critica letteraria
ISBN: 978-8804783299
Cartaceo 18,05€
Ebook 9,99€
Ascolta l'audiolibro
Quarta
Raffaello Baldini è un poeta grandissimo eppure pochi sanno chi è, e di quei pochi pochissimi ne hanno riconosciuto la voce. Perché scrive nel bel dialetto di Sant'Arcangelo di Romagna? Ma no. Paolo Nori ci rammenta che è poeta enorme anche nel bell'italiano con cui il poeta ha sempre tradotto a pie' di pagina i suoi versi. E quante storie si trascinano appresso quei versi, quante immagini suscitano, quanti personaggi, quanto universo c'è in quel mondo apparentemente piccolo. Come sua consuetudine, Paolo Nori attraversa l'avventura poetica di Baldini quasi come non ci fosse altro intorno, di sé facendo il filtro di una bellezza che viene su come da un fontanile e fa paura, perché ci lascia straniti. Ecco che - non diversamente da quanto è accaduto con Dostoevskji e Achmatova - l'immaginazione di Baldini si scioglie dentro quella di Nori, fatta com'è di caratteri e di accadimenti apparentemente minimi: i morti che "non dicono niente e sanno tutto", gli uomini che invece di calarsi gli anni se li crescono, lo stare lì di una donna davanti alla circonvallazione per guardare "che passa il mondo". Fra spinte e controspinte, fra il "cominciamo pure" e il "continuiamo pure" che ricorrono a battere il ritmo, impariamo che, sempre più, la scrittura di Nori è la messa a fuoco progressiva di un carattere, il suo: il suo essere "coglione", il suo essere "bastiancontrario", il suo essere "matto come un russo", il suo essere innamorato di un poeta come Raffaello Baldini, il suo magone davanti alla casa dei Nori come fosse una scatola di bottoni, il suo stare a vedere la vita come va avanti a ogni svolto imprevisto dello stare al mondo.
|
Davide Dotto |